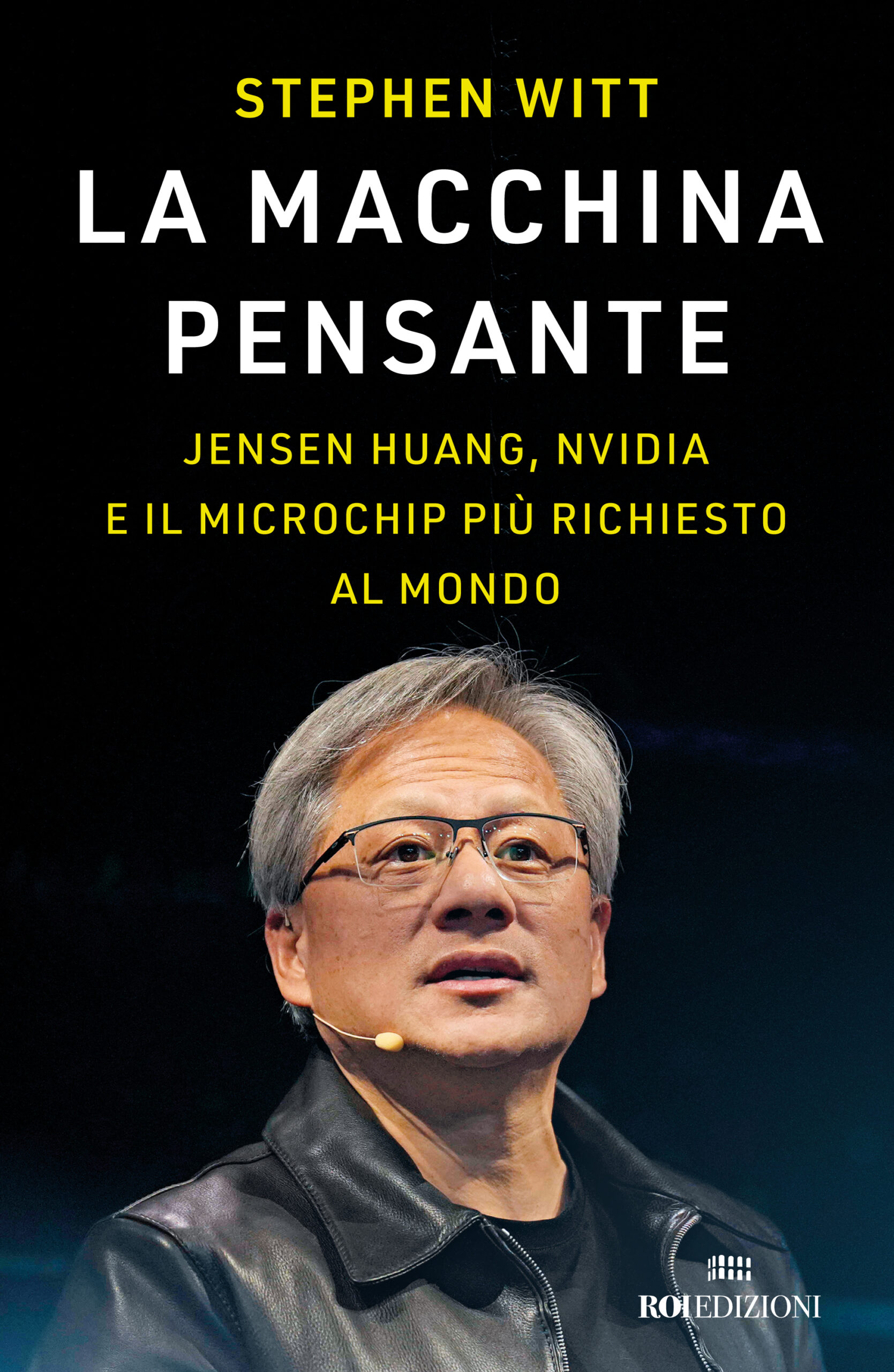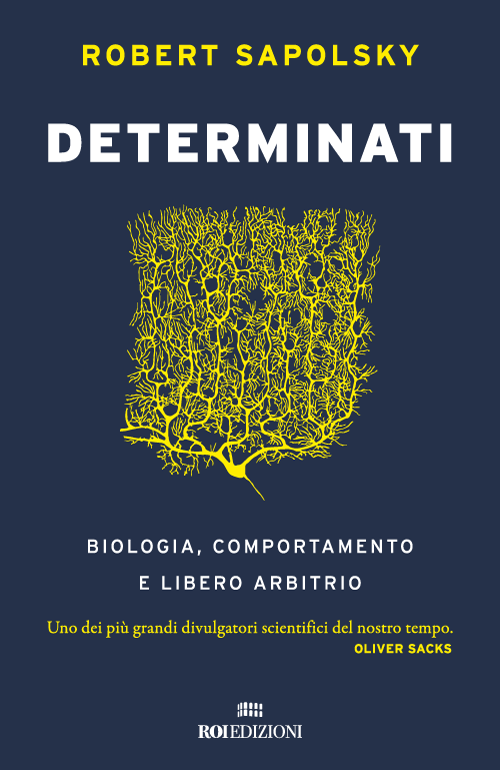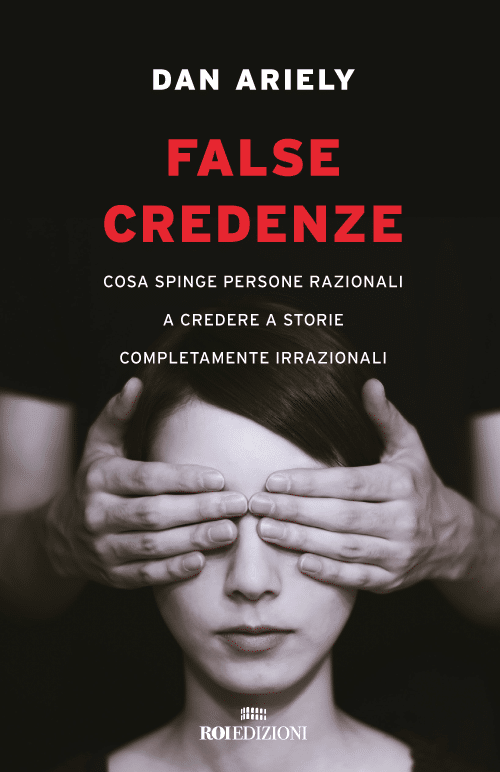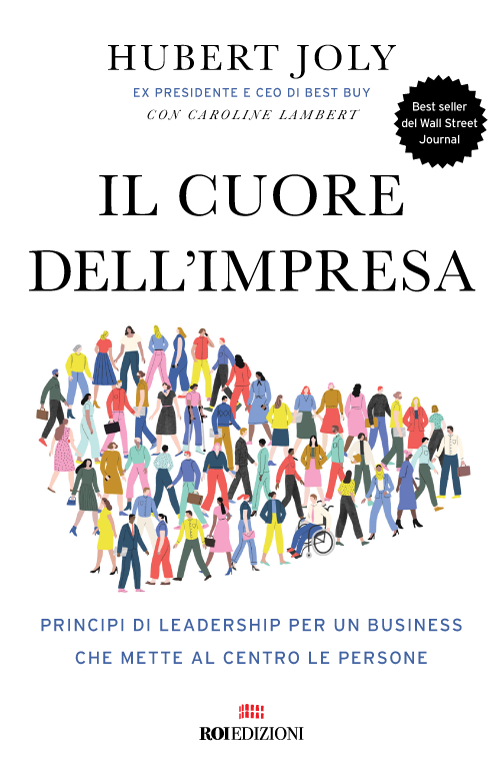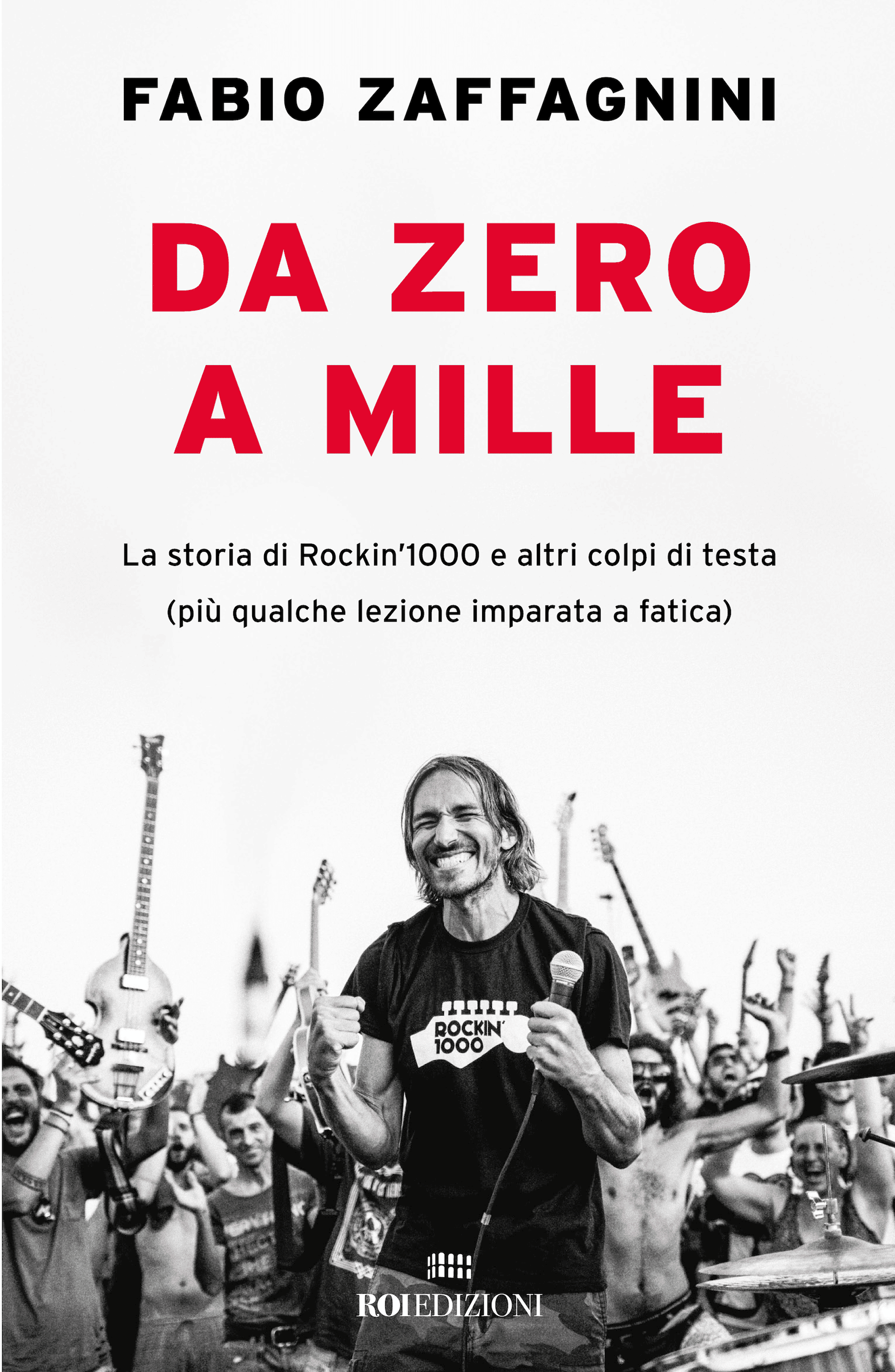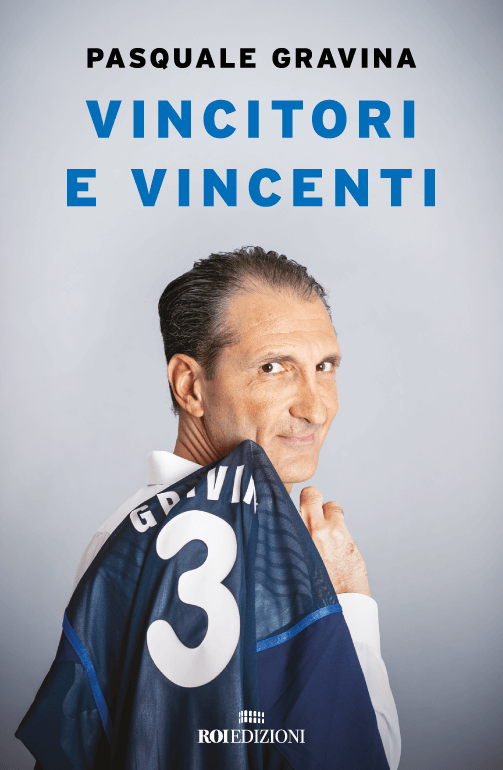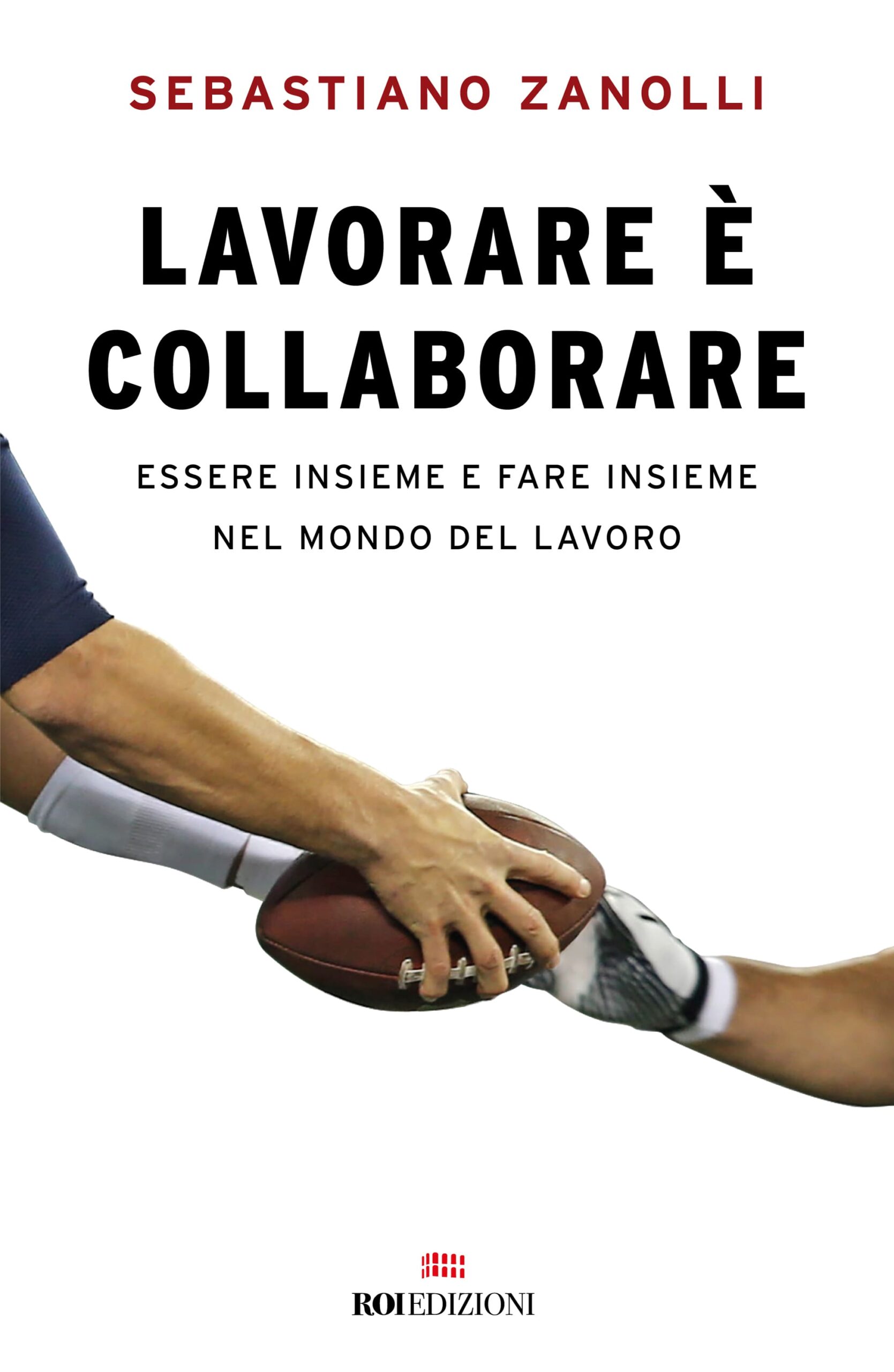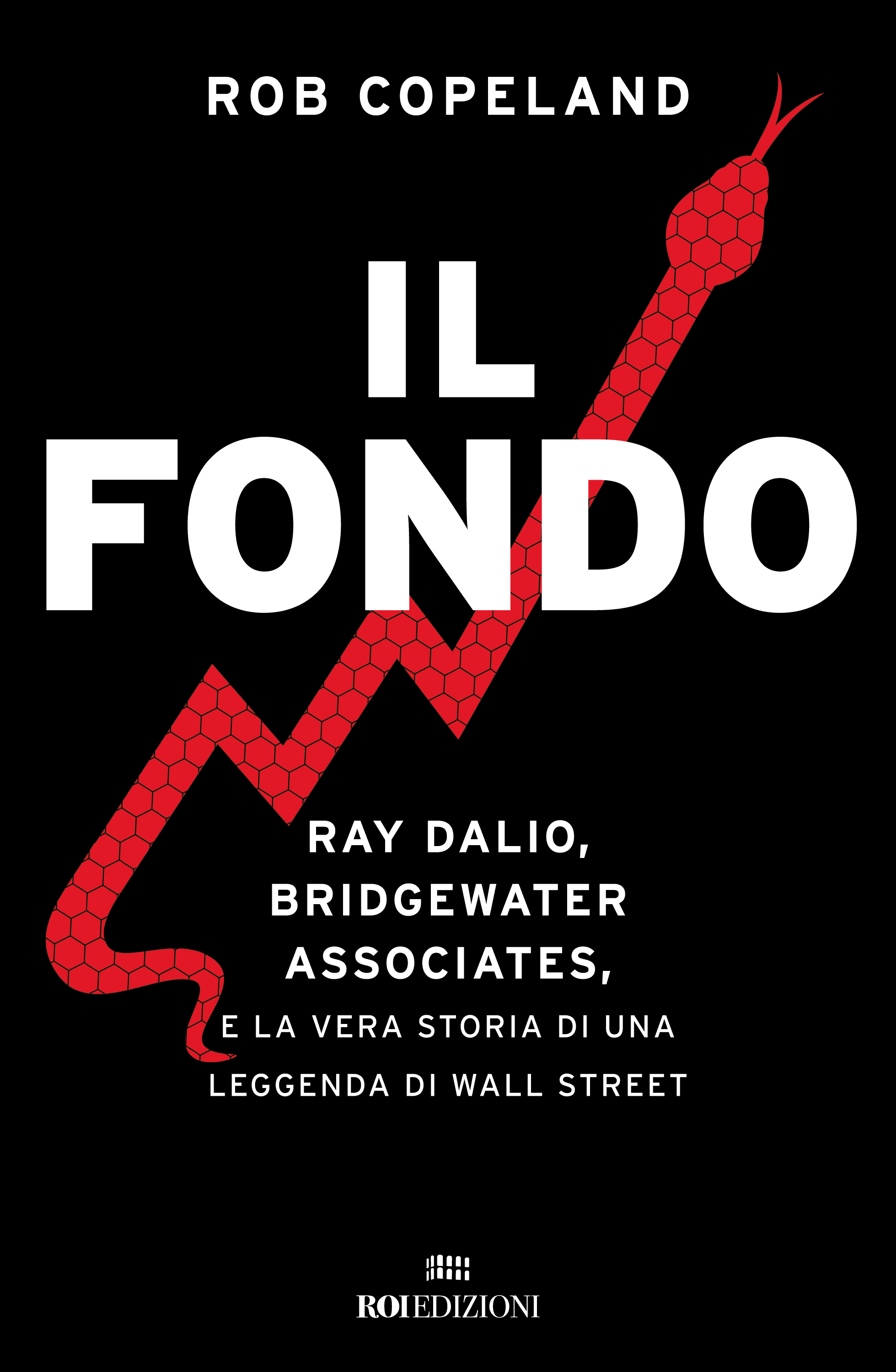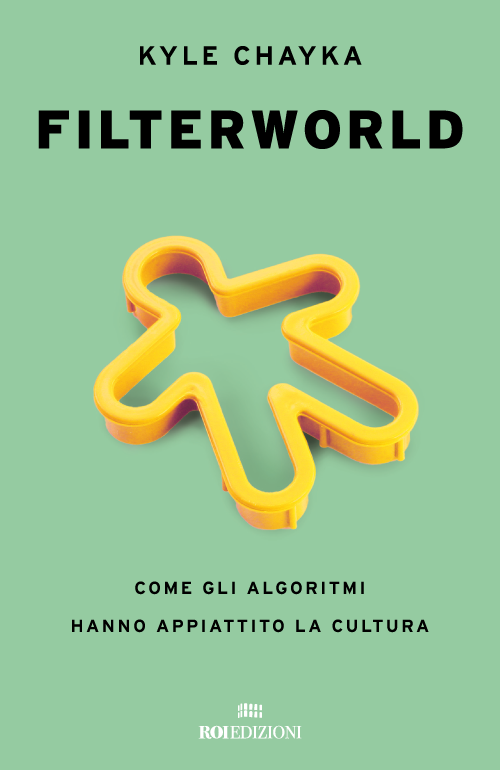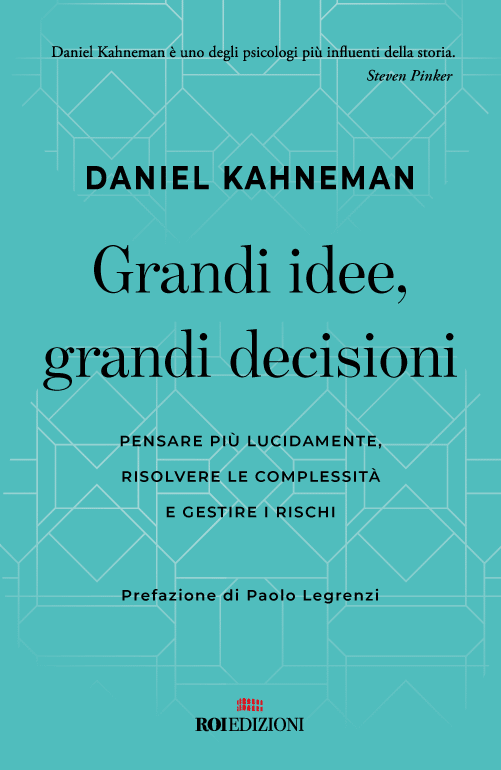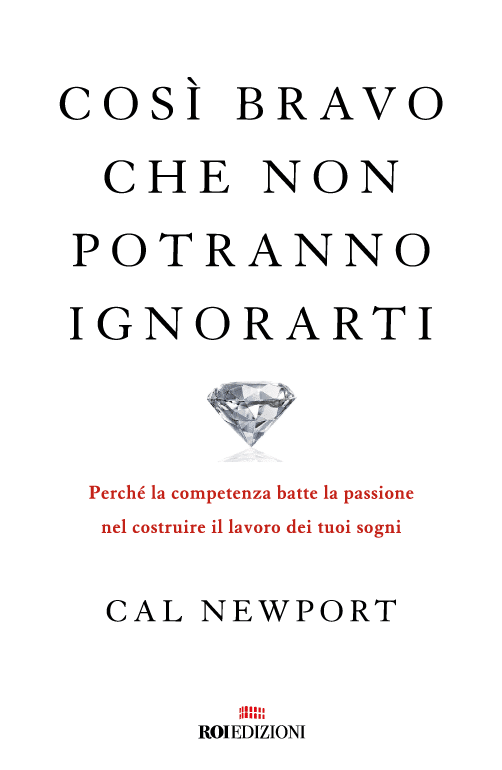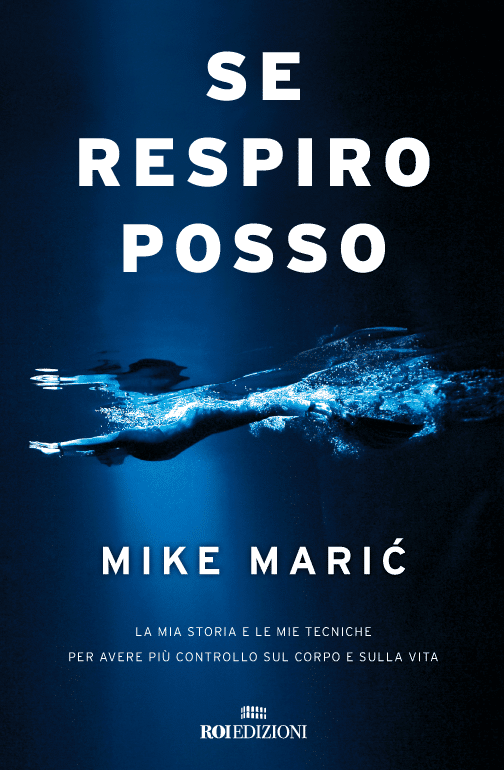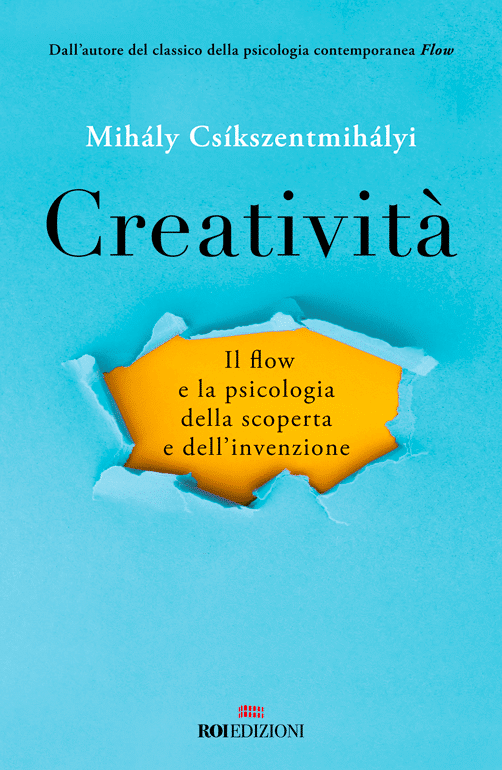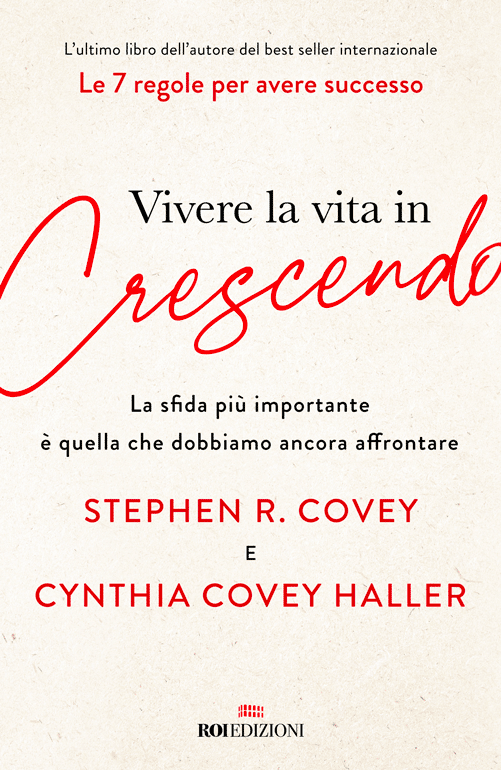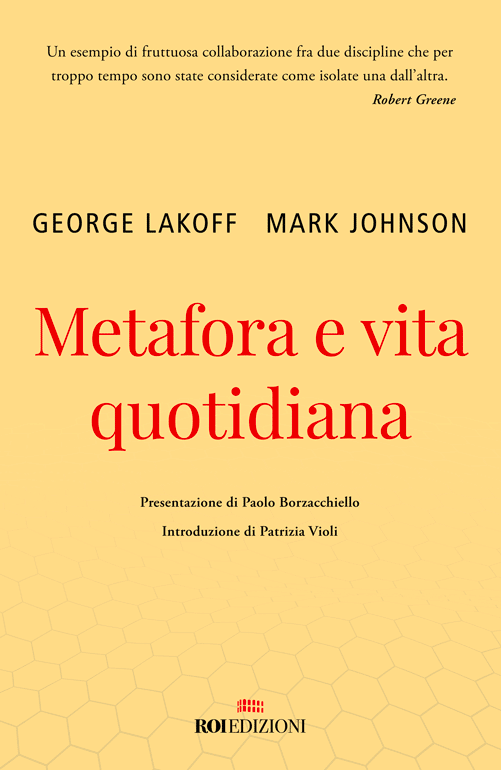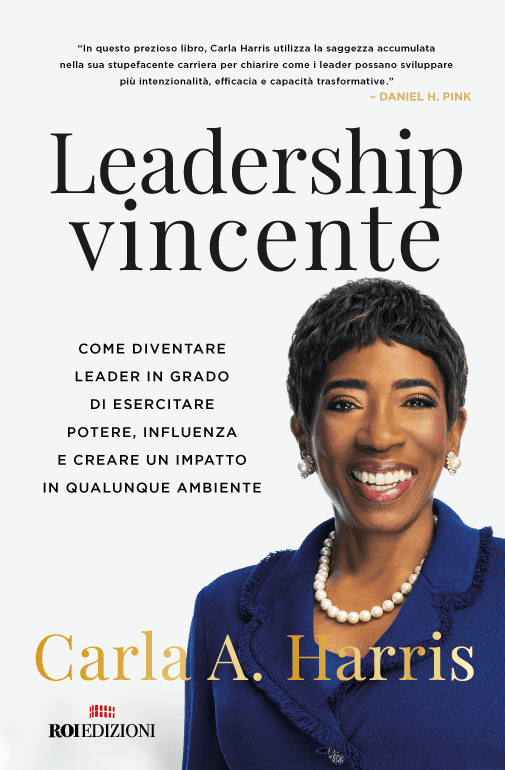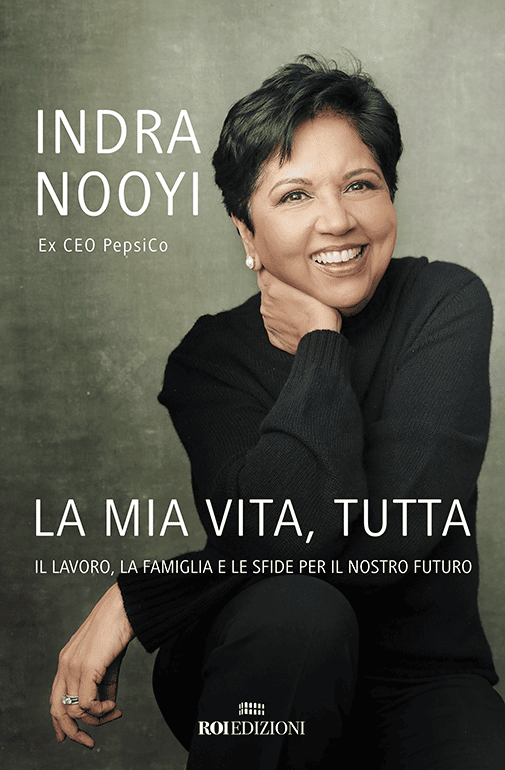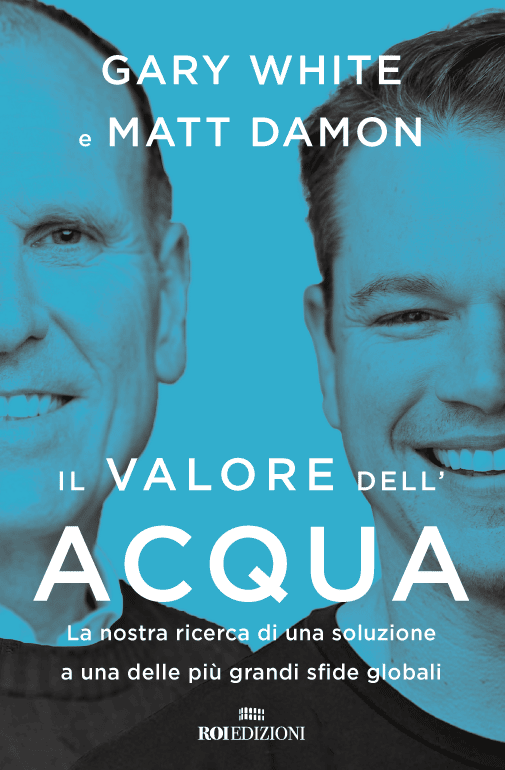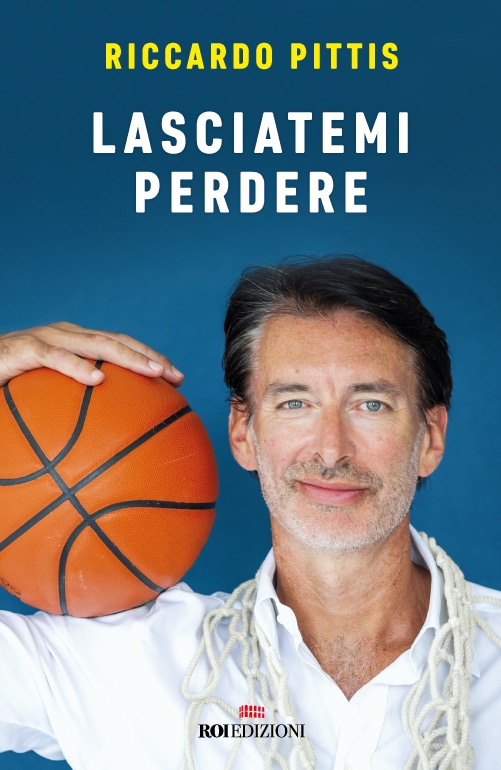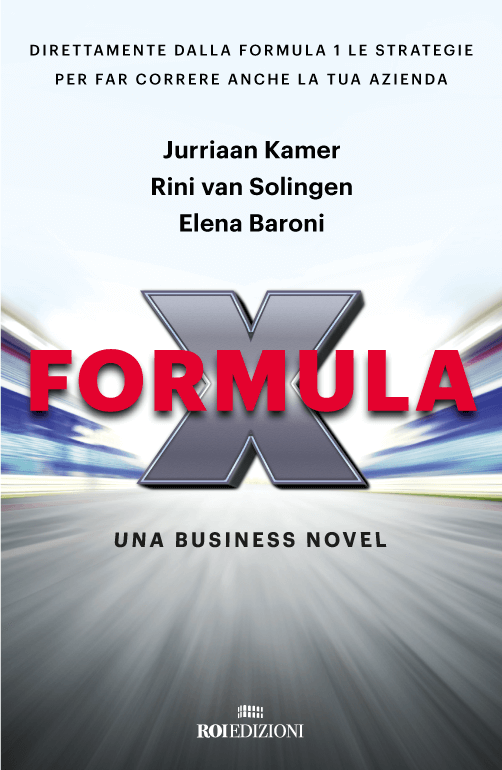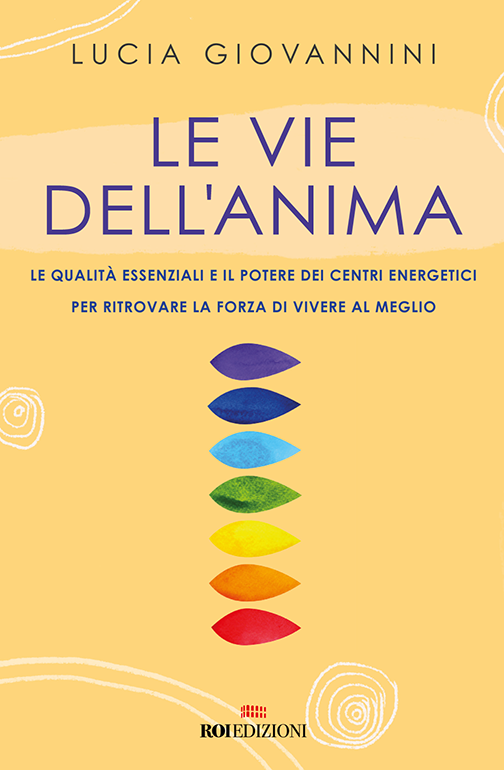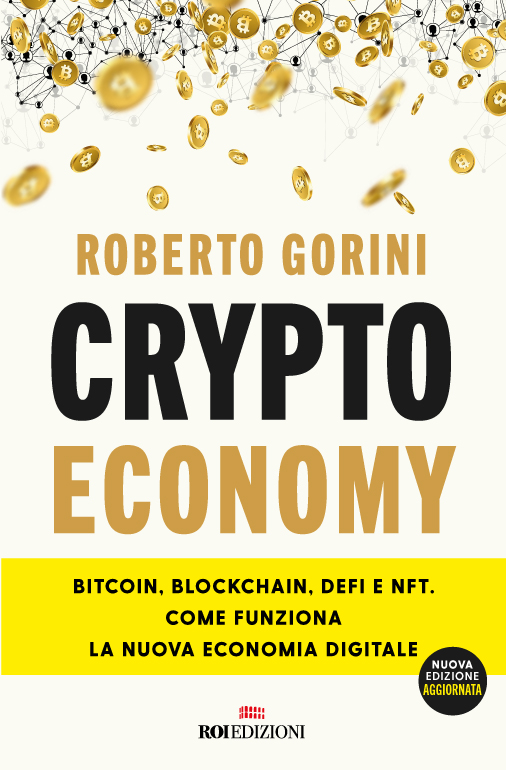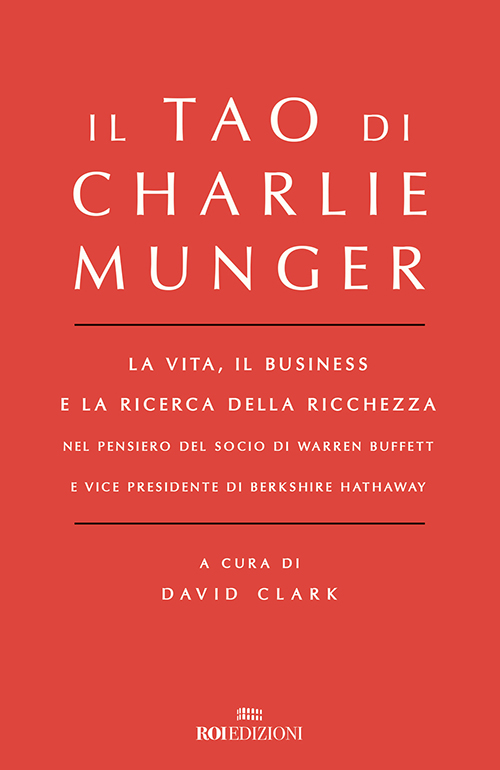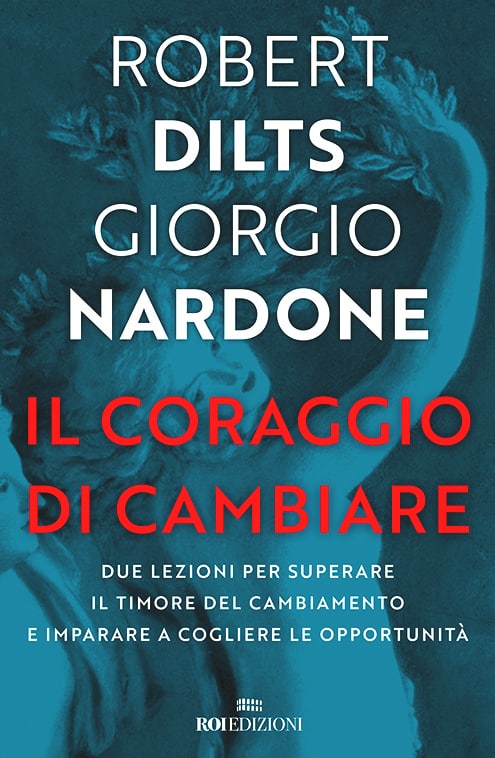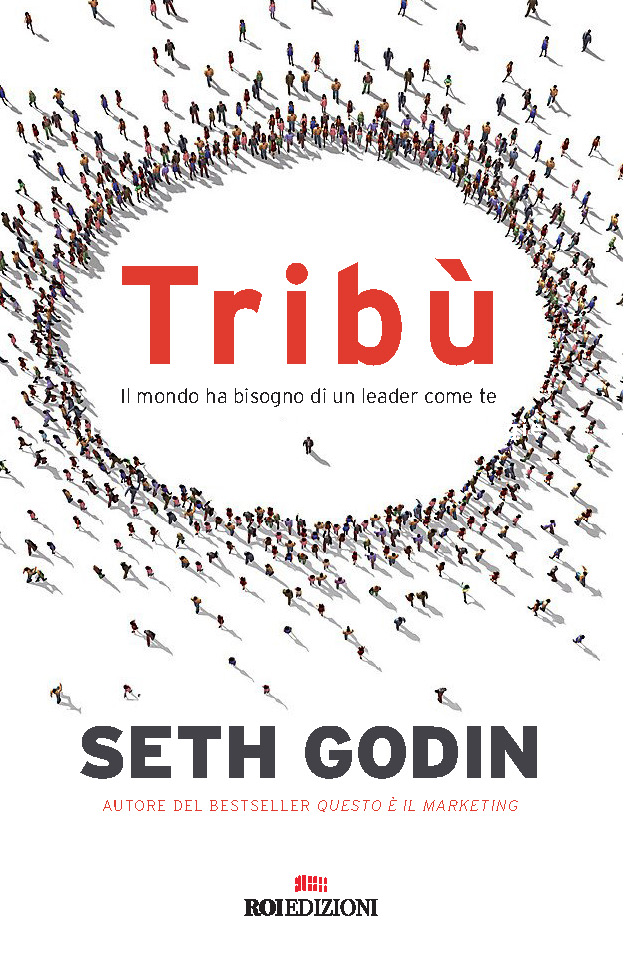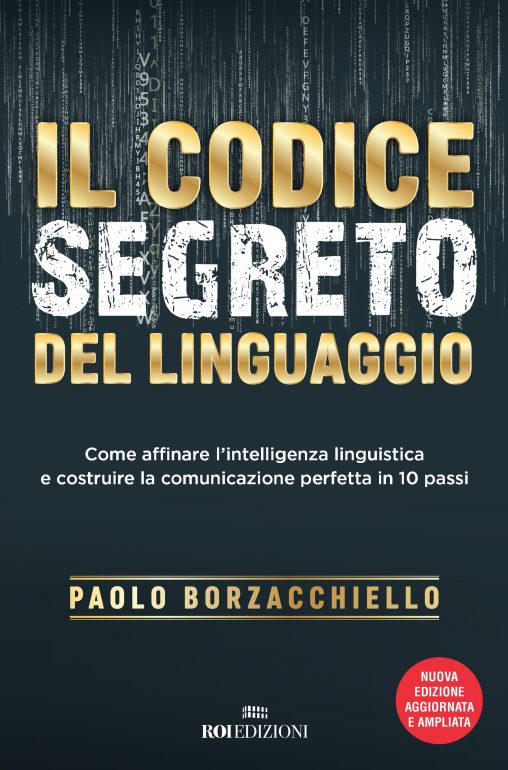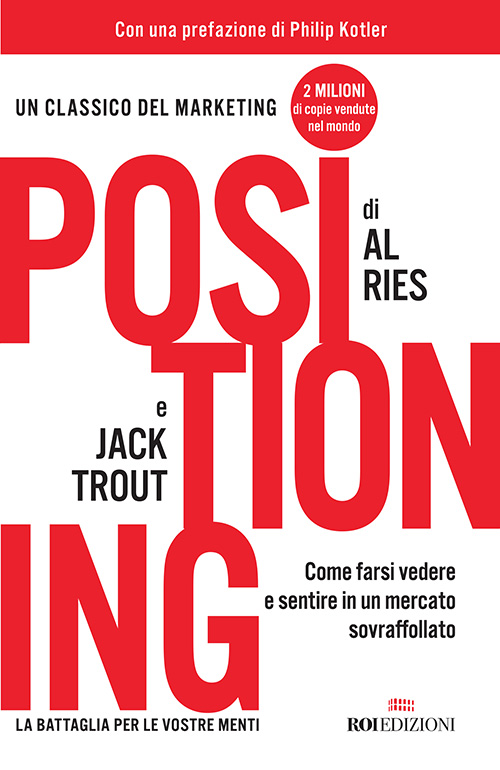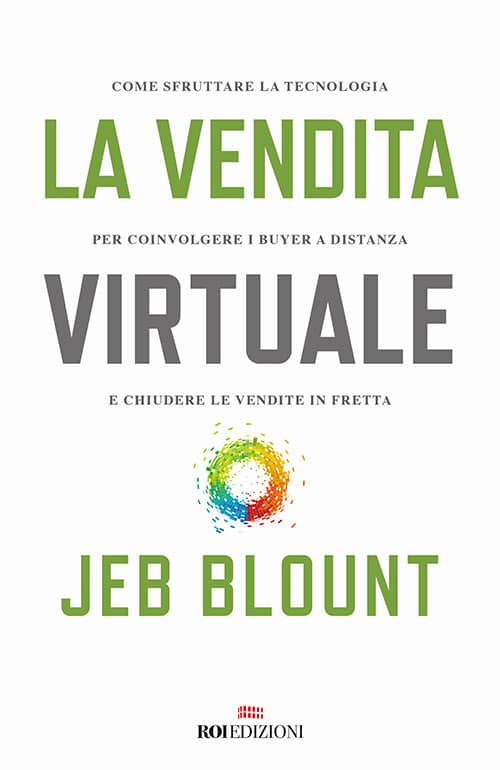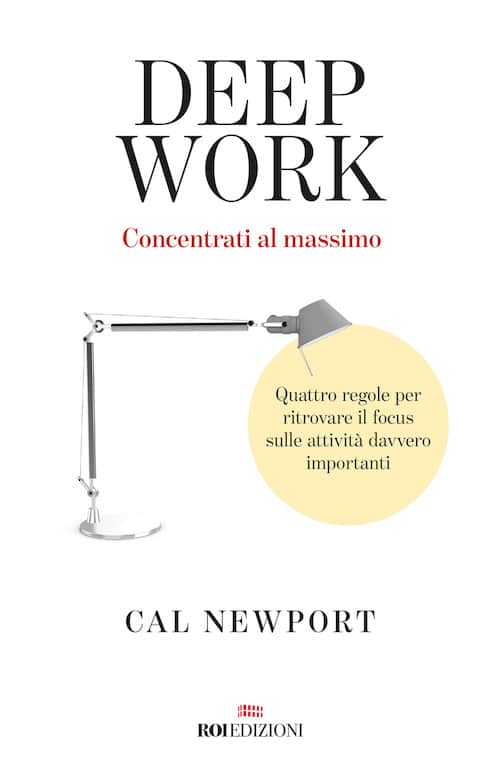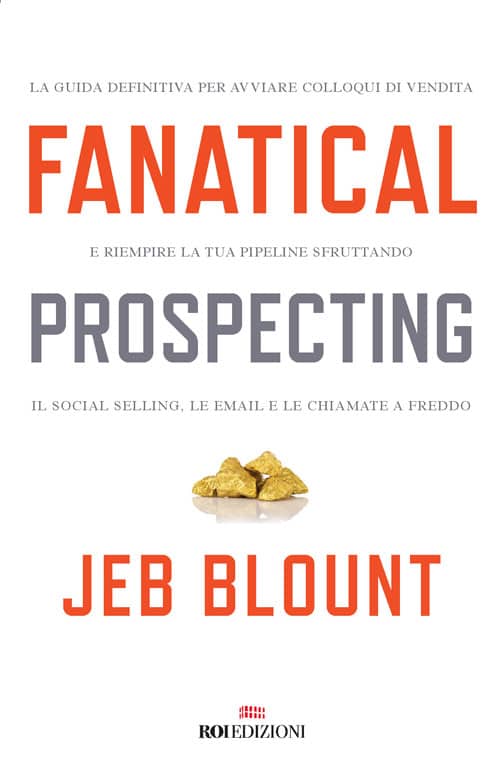La prima volta che ho assistito all’impossibile avevo nove anni. Era il 1976, l’anno della Coppa del Bicentenario, e a compiere l’impossibile è stato il mio fratellino. Lui aveva sette anni. Era pomeriggio inoltrato. Mio fratello era rientrato a casa dopo essere stato da un amico, aveva salutato la mamma e aveva estratto dalla tasca dei jeans sporchi di fango una palla di spugna di un colore rosso vivido. Misurava circa 3 centimetri di diametro ed era del colore del camion dei pompieri. Con le dita della mano destra, con calma, ha messo la palla nella mano sinistra che poi ha chiuso a pugno e sollevato verso il soffitto. Quindi ha chiesto a qualcuno – forse a me, forse alla mamma – di soffiare sul pugno chiuso. Mamma ha soffiato. E quando mio fratello ha aperto le dita, sono rimasto senza parole. La palla non c’era più. Intendo, puf! Scomparsa. Mio fratello – ne ero convinto – aveva compiuto l’impossibile.
Adesso, ovviamente, per molti, una palla di spugna che scompare non è poi un gran trucco. Però avevo nove anni e non avevo mai visto un gioco di prestidigitazione prima d’allora. Era proprio un’esperienza stupefacente. Ed era stupefacente da due punti di vista. Il primo e più ovvio: quella dannata pallina era scomparsa. Il secondo e un po’ meno ovvio: il mio fratellino non era magico. Di questo ero certo. Nei nostri sette anni di vita in comune, non aveva mai fatto nulla che sfidasse le leggi della fisica. Non si era mai messo a levitare accidentalmente e nessuno, quando la tazza da caffè preferita di papà non si trovava, l’aveva accusato di averla teletrasportata in altre dimensioni. Così, se mio fratello aveva realizzato l’impossibile e non era magico, ci doveva essere una spiegazione. Forse un insieme di competenze. Forse un metodo. È stata un’intuizione stupefacente. Intendo dire, che l’impossibile avesse una formula. E più di ogni altra cosa che avessi mai desiderato, volevo conoscere quella formula. Questo spiega molto di quanto è accaduto in seguito…