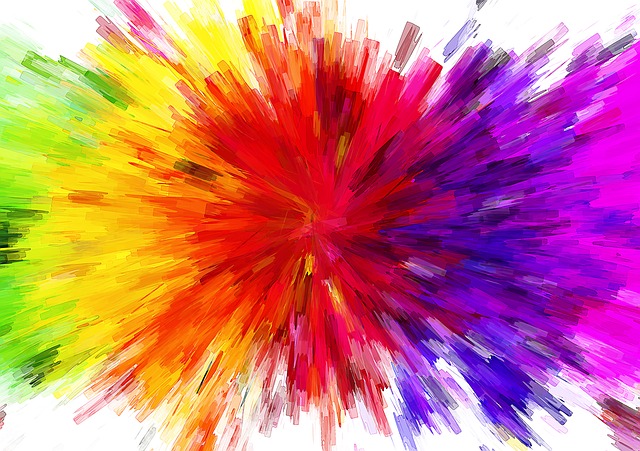I fondamenti storici, culturali e psicologici che riguardano le nostre ipotesi sulla mente – ovvero, che le proprietà che la caratterizzano siano individuali, intrinseche e prontamente classificabili in termini di qualità – garantiscono loro la possibilità di avere un potente impatto. Tali presupposti hanno profondamente plasmato le nostre opinioni in merito alla natura dell’attività mentale, alle strategie di sviluppo dell’istruzione e del lavoro, al valore che attribuiamo a noi stessi e agli altri. È quindi sorprendente dover contemplare che l’intero insieme di presupposti e conseguenze potrebbe essere stato mal concepito. Per cogliere la natura di questo errore, dobbiamo prendere in considerazione un’altra metafora.
La mattina del 18 aprile 2019, in una parte della città di Seoul, capitale della Corea del Sud, i monitor dei computer si sono improvvisamente oscurati. Nella metropoli, che si estende per oltre 600 km2 e nella quale vivono circa dieci milioni di persone, si sono spente le luci nelle scuole e negli uffici. Si sono spenti i semafori, agli incroci stradali, e i treni elettrici hanno rallentato, fino a fermarsi. La causa del blackout era ascrivibile a una causa di ridotta entità, ma i suoi effetti sono stati ingenti: l’interruzione della corrente era stata prodotta dalle gazze, gli uccelli dalle piume bianche e nere che costruiscono il nido sui tralicci e le torri di trasmissione della corrente elettrica. Le gazze, che fanno parte della famiglia dei corvidi, la quale comprende anche corvi, ghiandaie e cornacchie, sono famose per il fatto di costruire il nido con tutto ciò che è disponibile nell’ambiente.
È stato osservato che questi uccelli sono in grado di utilizzare una sorprendente varietà di materiali: non solo ramoscelli, spago e muschio, ma anche filo interdentale, lenze e rafia plastica colorata; bacchette, cucchiai e cannucce; lacci per le scarpe, montature per occhiali e porte per giocare a croquet. Nel corso delle Dust Bowl, le tempeste di sabbia che colpirono gli Stati Uniti durante gli anni Trenta del secolo scorso e che distrussero la vegetazione in enormi zone della parte occidente del subcontinente nordamericano, i cugini corvidi delle gazze costruirono i nidi con il filo spinato.
I quartieri urbani densamente popolati della moderna Seoul sono caratterizzati dalla scarsa presenza di alberi o cespugli, quindi le gazze usano quel che riescono a trovare: appendiabiti in metallo, antenne tv e fili di acciaio. Questi materiali conducono elettricità e così, quando gli uccelli costruiscono i nidi sulle alte torri di trasmissione della corrente elettrica della città, il flusso dell’elettricità viene frequentemente interrotto. Secondo la Korea Electric Power Corporation (KEPCO), le gazze sono responsabili di centinaia di interruzioni del flusso della corrente elettrica in diverse aree di tutto il paese. Ogni anno, i dipendenti della KEPCO lavorano per rimuovere più di diecimila nidi, ma, con altrettanta rapidità, le gazze li ricostruiscono.
Le gazze possono rappresentare un annoso problema per le società elettriche, ma la loro attività ci offre una feconda analogia in relazione al modo in cui funziona la mente. I nostri cervelli, si potrebbe dire, sono come le gazze: modellano i loro prodotti finiti a partire dai materiali che hanno a disposizione, intrecciando i frammenti che trovano nei loro pensieri. Accanto alle metafore cervello-computer e cervello-muscolo, è evidente che l’analogia cervello-gazza è di un tipo molto diverso, e implica conseguenze assai differenti in merito al modo in cui funzionano i processi mentali.
Per prima cosa: il pensiero non si compie solo all’interno della scatola cranica, bensì, anche al di là dei suoi limiti, ovvero nel mondo; è un’attività che implica un continuo montaggio e rimontaggio, e che attinge anche a risorse esterne al cervello. Inoltre, i tipi di materiali disponibili con cui “pensare” influenzano la natura e la qualità del pensiero che può essere prodotto. Infine, la capacità di pensare bene, cioè di dimostrarsi intelligenti, non è una proprietà persistente dell’individuo, bensì uno stato mutevole che dipende dall’accesso a risorse extraneurali e dalla conoscenza in merito a come sia possibile utilizzarle.
Questo è, certamente, un modo radicalmente nuovo di considerare il pensiero. Potrebbe essere un punto di vista non facile, o non naturale, da assumere. Eppure, una massa crescente di evidenze prodotte nel contesto di diverse discipline scientifiche indica che si tratta di un punto di vista molto più accurato in merito a come funzioni effettivamente la cognizione degli esseri umani. Inoltre, è una gratificante concettualizzazione generativa, perché offre tante opportunità, sul piano pratico, per migliorare il modo in cui pensiamo.
Tale concettualizzazione, potremmo dire, è giunta appena in tempo. La riformulazione del modello che rappresenta il modo in cui funziona la nostra mente, oggigiorno, è diventata una necessità urgente, poiché ci troviamo sempre più schiacciati tra due forze opposte: per un verso, abbiamo sempre più bisogno di pensare fuori dal cervello, per l’altro, siamo sempre più ostinatamente compromessi e condizionati dall’approccio brainbound. In primo luogo, per quanto riguarda la necessità crescente di pensare fuori dal cervello, come molti di noi possono facilmente riconoscere – in ragione del ritmo accelerato delle nostre giornate e nella crescente complessità dei nostri impegni scolastici o professionali –, le esigenze che riguardano il nostro pensiero diventano sempre più complesse e continuano ad aumentare. In altri termini, c’è una quantità maggiore di informazioni di cui dobbiamo occuparci. Le informazioni che dobbiamo elaborare si susseguono più velocemente. E il tipo di informazioni di cui dobbiamo occuparci è sempre più specializzato e astratto.
Quest’ultima differenza è particolarmente significativa. Le conoscenze e le abilità che siamo biologicamente preparati ad apprendere sono state superate dalla necessità di acquisire un insieme di competenze che manifestiamo in modo molto meno naturale e che acquisiamo con molta più difficoltà. David Geary, professore di psicologia all’Università del Missouri, pone un’utile distinzione tra le abilità “biologicamente primarie” e quelle “biologicamente secondarie”. Gli esseri umani, indica, fin dalla nascita sono pronti per imparare alcune cose: come, per esempio, parlare la lingua della comunità locale, orientarsi in un ambiente familiare, affrontare le sfide della vita in piccoli gruppi. Non siamo nati per imparare le complessità del calcolo, né le leggi controintuitive della fisica; non ci siamo evoluti per comprendere il funzionamento dei mercati finanziari o la complessità del cambiamento climatico globale. Eppure abitiamo in un mondo in cui tali abilità, biologicamente secondarie, costituiscono la chiave del progresso, e persino della nostra sopravvivenza. Le esigenze dell’ambiente moderno hanno ora raggiunto e superato i limiti del cervello biologico.
Per un certo periodo, è vero, l’umanità è stata in grado di mantenere il passo con la propria cultura in continua evoluzione, identificando, ingegnosamente, le modalità per utilizzare al meglio il cervello biologico. Man mano che i loro ambienti quotidiani diventavano intellettivamente più esigenti, le persone hanno risposto aumentando il loro impegno cognitivo. Tale impegno continuo con le asprezze che la vita moderna riserva alla mente – insieme al miglioramento dell’alimentazione e delle condizioni di vita, alla ridotta esposizione a malattie infettive e altri agenti patogeni – ha indotto, nel corso di un secolo, un incremento nel punteggio medio del QI, certificato dalle misurazioni prodotte dai test di intelligenza somministrati a persone di ogni cultura e in tutto il mondo. Ma quella traiettoria ascendente, oggigiorno, si sta appiattendo e stabilizzando.
Negli ultimi anni, i punteggi del QI hanno smesso di aumentare e, addirittura, hanno iniziato a diminuire. Alcuni ricercatori ritengono che le nostre risorse mentali siano state portate al limite. Può darsi che “il nostro cervello stia già lavorando in modo quasi ottimale”, osservano Nicholas Fitz e Peter Reiner, in uno scritto pubblicato sulla rivista Nature. Gli sforzi per estrarre ancora più intelligenza da questo organo, aggiungono gli autori, “urtano contro i rigidi limiti della neurobiologia”. Quasi per opporsi a questa sgradita verità, occorre riconoscere che, negli ultimi anni, i tentativi di superare tali limiti hanno ricevuto una crescente attenzione. Ma i farmaci e le tecnologie che un giorno potrebbero effettivamente migliorare l’intelligenza sono attualmente sottoposti alle prime fasi di sperimentazione.
Il modo migliore – e, almeno per ora, l’unico – per diventare più intelligenti è migliorare il pensiero al di fuori del cervello. Eppure respingiamo, o disprezziamo, questo tipo di cognizione, al punto che nemmeno la prendiamo in considerazione. Il nostro evidente bias a favore del pensiero brainbound ha un’origine lontana ed è ben radicato, ma è soltanto un pregiudizio, che non può più essere sostenuto e, per di più, non appare supportato da evidenze. Il futuro è rappresentato dal pensare fuori dal cervello.